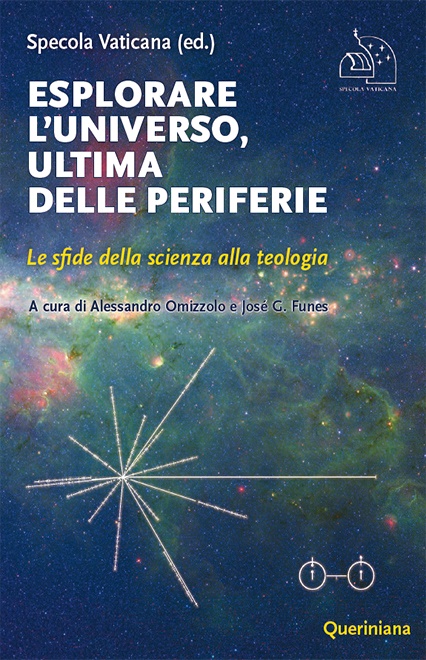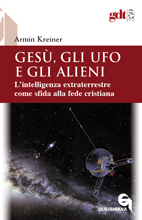Il premio Nobel per la fisica è andato agli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz per i loro lavori sugli esopianeti. Quali le implicazioni a livello teologico?
26 dicembre 2019 in scienza , cristianesimo , teologia
(Anne-Sylvie Sprenger) La domanda è semplice: l’esistenza di esopianeti, cioè pianeti al di fuori del nostro sistema solare, implica necessariamente l’esistenza di forme di vita extraterrestre? La risposta non è altrettanto semplice. Di certo i lavori degli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, insigniti del premio Nobel per la fisica, hanno scombussolato le ricerche in questo campo.
Facciamo il punto della situazione con Jacques Arnould, incaricato di etica al Centro nazionale di studi spaziali e autore di numerosi lavori all’incrocio tra scienze e teologia, tra i quali Turbulences dans l’univers: Dieu, les extraterrestres et nous (“Turbolenze nell’universo: Dio, gli extraterrestri e noi”, ed. Albin Michel).
Come valuta il riconoscimento conferito oggi ai fisici Michel Mayor e Didier Queloz?
Prima di tutto, mi lasci dire: era ora! Non bisogna dimenticare che la scoperta da parte di Michel Mayor e Didier Queloz del primo pianeta fuori del nostro sistema solare risale al 6 ottobre 1995! Un’attesa di ventiquattro anni prima di essere ricompensati per uno dei maggiori successi dell’astronomia della fine del 20.esimo secolo: decisamente, la pazienza è una delle qualità principali dell’astronomo!
Perché i loro lavori sono significativi in ambito scientifico?
Una delle principali questioni con cui gli scienziati devono confrontarsi quotidianamente consiste nel determinare se la realtà da essi osservata, il processo che studiano è unico, raro o comune. In astronomia l’esistenza di pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal nostro Sole era rimasta problematica fino all’ottobre del 1995: il nostro sistema solare è unico oppure no? Fornendo una risposta a questa domanda i due premi Nobel hanno aperto un nuovo capitolo dell’astronomia che, a partire da quella data, si è rivelato ricco di scoperte, di sorprese, persino di stravolgimenti di idee fino ad allora comunemente ammesse.
Come s’è sviluppata la ricerca scientifica in merito alla questione dell’esistenza o no di forme di vita extraterreste?
Il lancio dello Sputnik nel 1957 e l’inizio dell’era spaziale hanno ovviamente influenzato i lavori degli scienziati per quanto riguarda la ricerca di forme di vita extraterrestre. Alle congetture filosofiche e teologiche – le cui prime tracce risalgono al secondo millennio prima della nostra era – e alle osservazioni condotte con l’ausilio di telescopi terrestri, si sono infatti aggiunte le missioni di esplorazione della Luna, di Marte e del sistema solare. Sono nate così le discipline dell’esobiologia e dell’astrobiologia che articolano discipline che fino ad allora non avevano cercato o non avevano avuto l’occasione di collaborare: astrofisica e astronomia, fisica delle atmosfere e chimica delle forme di vita primitiva, studio delle origini della vita e delle sue evoluzioni eccetera. Anche le scienze umane sono invitate a unirsi a questa singolare “cospirazione”!
E oggi a che punto sono i progressi di questi lavori di ricerca?
Il settore sta facendo passi da gigante: alla scoperta di esoplaneti inaugurata da Mayor e Queloz [a tutt’oggi ne sono stati censiti oltre 4.000, ndr.] si aggiungono i lavori condotti sui pianeti più prossimi; si pensi alle prodezze dei robot sulla superficie del pianeta Marte o all’atterraggio della sonda spaziale Philea sulla superficie della cometa Tchouri: tante opportunità di andare a caccia di possibili “particelle elementari della vita”!
Sulla Terra i ricercatori vanno a caccia delle minime tracce di vita nelle condizioni più estreme: laghi ghiacciati, fondali marini, aree vulcaniche; hanno persino “creato” una nuova categoria di organismi viventi: gli estremofili, in altre parole organismi che “vanno matti” per condizioni considerate solitamente proibitive. Tante opportunità, come si può ben comprendere, per interrogarci anche sulle condizioni di emergenza e di evoluzione degli organismi viventi, sulle caratteristiche che un ambiente, un pianeta deve possedere per poter essere considerato abitabile. Tuttavia, malgrado tutti i nostri sforzi, non abbiamo ancora trovato forme di vita in un altro posto che non sia la Terra…
Lei ha scritto “Turbulences dans l’univers, Dieu les extraterrestres et nous” (“Turbolenze nell’universo: Dio, gli extraterrestri e noi”). La Bibbia, però, non sembra affrontare mai la questione…
L’ipotesi di una vita extraterrestre non è l’unica questione che non viene affrontata dalla Bibbia! Non vi si legge nemmeno della scoperta del Nuovo Mondo, degli antibiotici o della televisione… Cercare di trovare nel testo sacro risposte a tutte le domande, a tutti i problemi, teorici o pratici, che possiamo, noi esseri umani, porci sarebbe cedere a uno dei difetti di lettura più gravi che ci siano: il concordismo. Con questo intendo riferirmi alla tendenza, alla volontà di porre la Bibbia al nostro livello, al nostro servizio, per rassicurarci o assicurare il nostro potere.
La scienza non contraddice i testi biblici?
Lo sviluppo delle scienze, soprattutto a partire dal 17.esimo secolo, ha in qualche modo scombinato le convinzioni religiose, in particolar modo quelle cristiane. La nostra visione del mondo, della vita, dell’essere umano è stata profondamente modificata dal lavoro di scienziati come Galileo Galilei, Johannes Kepler, Charles Darwin, Albert Einstein e tanti altri, fino a Mayor e Queloz! Ma perché aver paura?
Sebbene la Bibbia non affronti direttamente la questione della vita extraterrestre, non manca in compenso di risorse per invitarci a riconsiderare il nostro modo di posizionarci al centro dell’universo. Iniziamo leggendo di nuovo tutti i racconti della creazione, non soltanto quelli del libro della Genesi, ma anche quelli presenti nel libro dei Salmi, nel libro di Giobbe: confessare l’opera creatrice di Dio non significa attenervisi, chiudersi nel calendario quasi liturgico del primo capitolo della Genesi o dover difendere un rigido antropocentrismo.
Ampliamo i nostri orizzonti, scopriamo la dimensione cosmica di certi Salmi o di certi inni cristologici. Certo, non è una questione di “omini verdi”, ma piuttosto di guardare al di là del nostro orizzonte, di aprirci a questa novità che Dio non ha mai smesso di promettere ai suoi eletti.
Più precisamente, quali sono le implicazioni a livello teologico dei risultati dei lavori di Mayor e Queloz?
Finora non abbiamo trovato organismi viventi al di fuori del nostro pianeta. Certo, le probabilità di trovarne sono aumentate, in particolare con la scoperta degli esopianeti; ma ciò non significa che faremo senza dubbio “tombola”! Dobbiamo renderci conto che la risposta all’interrogativo sulla vita extraterrestre è inevitabilmente sbilanciata: soltanto l’affermazione della sua esistenza è possibile; quella della sua inesistenza è impossibile perché non riusciremo mai a ispezionare ogni angolo del nostro universo.
E dal punto di vista del teologo?
Il teologo cristiano può interrogarsi sulle conseguenze dell’esistenza di forme di vita e anche di intelligenza in un altro posto che non sia la Terra: può condurre quella che gli scienziati chiamano un’esperienza di pensiero. In altre parole, come pensare, come dire e spiegare la fede cristiana, nel caso in cui Dio avesse creato altri esseri viventi, altri esseri intelligenti. Non dobbiamo aver paura di una tale possibilità: nel 13.esimo secolo il vescovo di Parigi spiegò giustamente che non possiamo porre limiti alla capacità e alla volontà divina di creare.
Certo, le difficoltà non mancano: dal 17.esimo secolo in poi quella della possibilità di una Incarnazione e di una Redenzione in un altro posto che non sia la Terra ha diviso la comunità dei teologi; ancora oggi questa prospettiva può apparire vertiginosa. Consideriamola almeno come un invito a (ri)scoprire la dimensione cosmica della nostra cristologia.
Si può essere cristiani e credere negli extraterrestri?
Mi piace questa domanda, perché ci invita a non mescolare le nostre mode, i nostri modi o le nostre ragioni per credere. Gli extraterrestri appartengono a quei soggetti di fede che sembrano imporsi a noi: a furia di guardare nei nostri telescopi non possiamo sfuggire alla questione della loro esistenza e siamo costretti a decidere se crederci o no, in attesa di scoprirne tracce o di ricevere una loro visita. Ma possiamo anche decidere di non occuparcene! Essere cristiani, credere in Dio è qualcosa di diverso: è una questione vitale. L’incontro di Gesù e di Marta al momento della morte di Lazzaro non è un incontro del terzo tipo, cioè fra una terrestre e un extraterrestre. La domanda che Gesù pone a Marta è essenziale: “Credi nella risurrezione? Credi in me?”. E Marta vi impegna tutto il suo cuore, tutta la sua mente. Un tale incontro, una tale fede non sono extraterrestri: sono straordinari! (da ProtestInfo; trad. it. G. M. Schmitt)